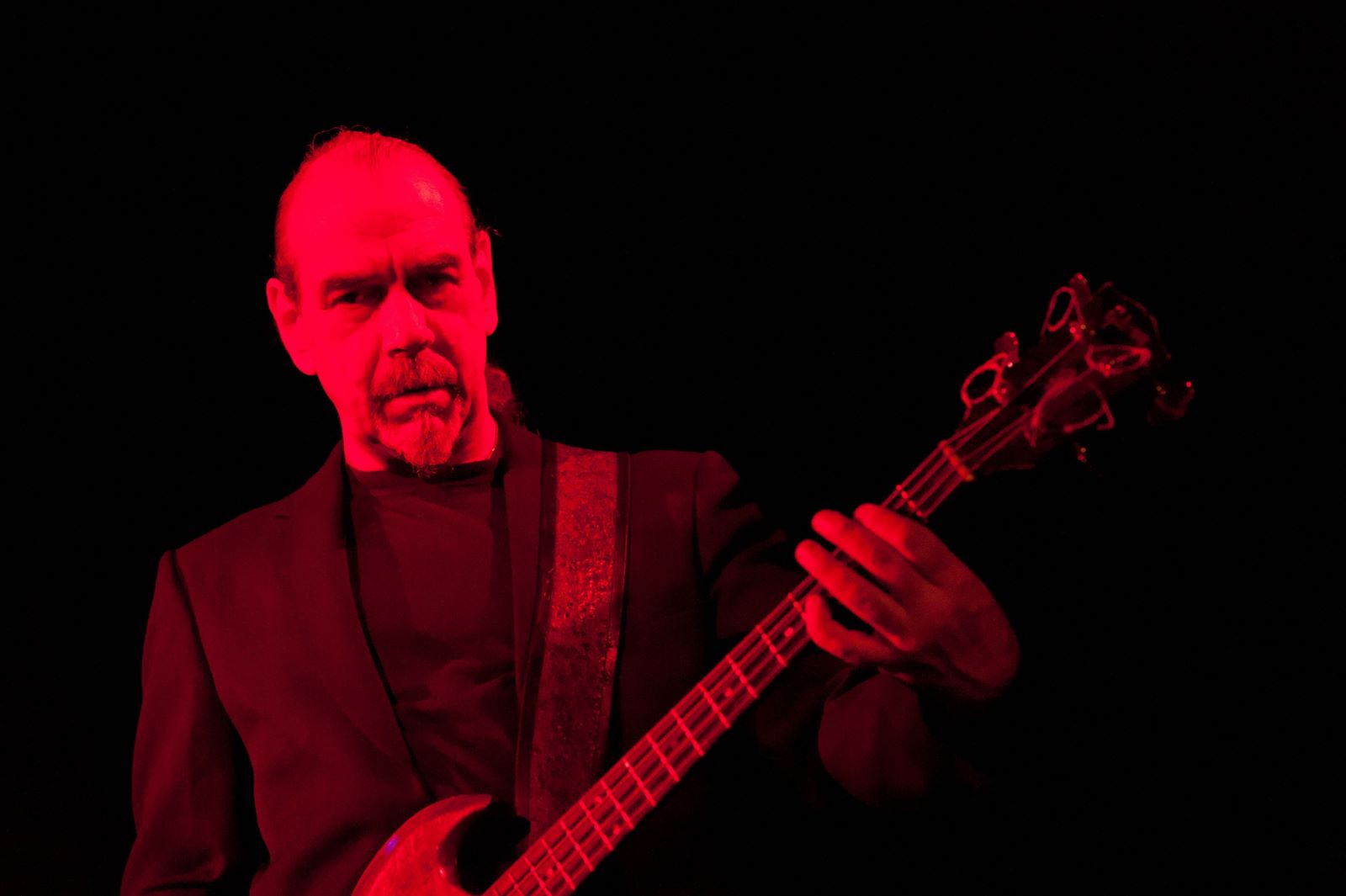Come alieni proiettati nel futuro, i Tuxedomoon bruciano in fretta le tappe della loro rivoluzione. Esplosi nel calderone underground di San Francisco, terra di fricchettoni e folli sperimentatori – dai Residents a MX-80 Sound e Chrome - si scoprono presto pesci fuor d’acqua. L’America a cavallo tra i decenni 70 e 80 è affamata di ardore rock e autenticità. Blaine L. Reininger e compagni, figli degeneri del punk, sono già un passo avanti. Con il loro cabaret grottesco cavalcano fino in fondo l’artificiosità, per smascherare la falsa spontaneità del rock, con i suoi vetusti rituali e cliché. In più, presagiscono già l’elettronica che dominerà il decennio, e la iniettano a dosi massicce nei loro psicodrammi esistenzialisti. “Il punk si era fossilizzato in un dogma puritano di chitarre, basso, batteria e un cantante che urla – spiegherà Steve Brown (tastiere, sax) - ma quando Blaine e io iniziammo a esibirci dal vivo – un violino, un sax, un synth e un registratore – la gente ci bersagliava di bottiglie e gridava ‘Dov’è il batterista?’ Il ritmo programmato era un concetto alieno nell’America di quei giorni”.
Il loro teatro dell’assurdo, dunque, era condannato a espatriare, e la destinazione naturale non poteva non essere il Vecchio Continente.
In Europa, i Tuxedomoon avevano già saggiato l’entusiasmo del pubblico durante il tour di “Half-Mute”, il loro formidabile esordio. Sorpresi da tanto clamore, gli ex-freak di San Francisco decidono di piantare le tende proprio nel Vecchio Continente, installando il loro quartier generale prima ad Amsterdam (Olanda), quindi a Bruxelles (Belgio) dove trascorreranno un periodo molto lungo e prolifico. Nel frattempo, a Londra, hanno registrato il loro secondo album, “Desire”. Un'altra rivoluzione.
È la grafica, anzitutto, a preannunciare il cambio di rotta. Al posto delle linee geometriche e astratte di “Half-Mute”, sulla copertina di “Desire” campeggia una immagine più calda, velatamente erotica, che pare celare un’imprecisata anatomia umana. Si smussano gli angoli, quindi, con suoni più morbidi e rotondi in luogo delle sgraziate spigolosità dell’esordio. E si riempiono gli spazi: laddove “Half Mute” innalzava monumenti al vuoto (addirittura “Fifth Column” era presente nella versione non cantata, sembrando così uno strumentale), “Desire” risulta più denso ed epico, grazie anche a una robusta sezione ritmica e a un uso più marcato dell’elettronica.
Ma la vera rivoluzione è nell’amplesso (proibito) tra l’algida avantgarde dei californiani e quel synth-pop che all’alba del decennio 80 stava invadendo le classifiche. Un’operazione talmente temeraria che forse solo loro potevano concepire e portare a termine con successo. Certo, c’erano già riusciti i Kraftwerk di “Trans Europe Express”, ma la loro alchimia, parimenti oltraggiosa, era più sbilanciata verso il pop. I Tuxedomoon, invece, riescono a far dialogare due linguaggi apparentemente agli antipodi utilizzando lo stesso approccio colto e incompromissorio degli esordi. Fino alla provocazione massima: la musica da camera che sbarca in discoteca.
Prendiamo ad esempio la suite iniziale, una liturgia esoterica di un quarto d’ora, suddivisa in 4 parti: nella prima, l’ipnotica “East”, è il sax lunare di Brown a ricamare sui cupi rimbombi del basso mentre il violino mefistofelico di Reininger stride in lontananza; nel seguito "Jinx" torna lo strumento del Diavolo a sfregiare un balletto meccanico per note minori, impreziosito da una melodia gitana e dai vocalizzi stranianti del cantante-mimo di origine cinese Winston Tong; il terzo segmento (“…”), un breve interludio dissonante per archi ed effetti elettronici, prepara il terreno alla sinfonia cacofonica della conclusiva “Music #1”, tripudio di synth imbizzarriti, found sounds e rumori psicotici ai confini della musica concreta.
Ma proprio al culmine del loro più glaciale climax avanguardistico, Reininger & C. sterzano verso i caldi lidi del synth-pop per intonare un’ode all’infausto destino della dea Cassandra, profetessa inascoltata per vendetta divina: “Victims Of The Dance” sublima il loro teatro della crudeltà in una litania grottesca, scandita dal basso in scala discendente del compianto Peter Principle e trafitta da effettismi e controvoci spettrali. Come dei Roxy Music posseduti dal demonio. È di fatto un nuovo genere musicale, un “synth-pop noir da camera”, che non si vergogna di contaminare il suo lignaggio aristocratico con il sudore del dancefloor: ecco allora la prodezza di “Incubus (Blue Suit)”, dove irrompe il battito martellante di una drum-machine a pompare cadenze quasi disco, con un giro di synth vertiginoso alla Jarre e stridenti stacchi di chitarre. A far da contrappeso al ritmo scatenato, un testo tetro e apocalittico, che evoca un uomo giunto dal futuro per donare l’arma letale a un’umanità ormai agonizzante: “L’odore di metallo fuso permea la scena, la musica suona in sale vuote”. Mai la dance era stata così tragica.
Sempre col piede piantato sull’acceleratore, i Tuxedomoon pennellano l’alienante title track, propulsa dai borbottii del basso e da poliritmi impazziti, con un cantato gelido, asettico, che scandisce ossessivamente slogan programmatici (“Desire/ Don't think/ Don't buy”, quasi un inno contro il logorio della società dei consumi), mentre il sax schizofrenico di Brown graffia in libertà. Quindi, riaprono i battenti della loro discoteca decadente e ad accoglierci è il più imprevedibile dei dee-jay: l’ineffabile Winston Tong, che dopo l’intro solenne di tastiere e sax, annuncia: “What suffering, in the name of love”, e via alle danze: una chitarra si affaccia timida, subito travolta dalle pulsazioni forsennate della sezione ritmica e da un altro prodigioso giro di synth: è l’istantanea definitiva dell’amplesso tra new wave e dance. Epico, struggente, “In The Name Of Talent (Italian Western Two)” resterà uno dei grandi inni sotterranei del decennio, con tanto di testo-parabola sul destino sventurato di chi sacrifica il proprio talento.
Chiudono il cerchio due episodi apparentemente minori, ma sempre pervasi da una folle creatività: la ballata jazzata di "Again", dove il ritmo rallenta, lasciando spazio ai bagliori crepuscolari del sax e al crooning bislacco di Tong, e il congedo demenziale di "Holiday For Plywood", a metà tra pantomima da cabaret e fiaba disneyana, dove torna il tema della paranoia consumistica, attraverso l’angoscia suscitata da una casa dei sogni: “Don't sit on the sofa/ The plastic makes you sweat/ The bathroom's done in mirror tiles/ The toaster wants your blood” (“Non osi sederti sul divano/ La plastica ti fa sudare/ Il bagno è in piastrelle a specchio/ Il tostapane vuole il tuo sangue”).
Con “Desire”, i Tuxedomoon scandalizzano i pasdaran dell’avanguardia, mettendosi a flirtare appassionatamente con i fenomeni più in voga dell’epoca (synth-pop, dance), e terrorizzano al tempo stesso i seguaci di questi ultimi, con le loro visioni distopiche da un agghiacciante futuro industriale, alienato e disumanizzante.
Del resto, il loro eclettismo non sorprende, se si pensa che lo stesso Reininger citò tra le fonti sonore della band “muzak americana, cose che suonano nei supermercati, canzoni italiane o messicane, standard elettronici, musica tradizionale e cose di questo genere”. E in questo caso c'è anche il supporto non indifferente di una produzione più professionale (è il loro primo disco registrato su ventiquattro piste).
Notturno, visionario, raggelante, “Desire” è il secondo capolavoro sfornato in poco più di un anno dall’ensemble di San Francisco. Diffidate di chi lo sminuisce. E non lasciatevi sfuggire la ristampa con accluso l'Ep "No Tears" (1978): niente lacrime per le creature della notte, oggi come allora.
In memoria di Peter "Principle" Dachert (New York, 5 dicembre 1954 - Bruxelles, 17 luglio 2017)
03/06/2018
Tracklist
- East/ Jinx/ …/ Music #1
- Victims of the Dance
- Incubus (Blue Suit)
- Desire
- Again
- In the Name of Talent (Italian Western Two)
- Holiday for Plywood (Holiday for Strings)